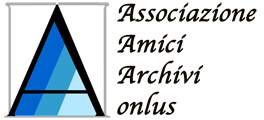I termini documento e monumento derivano rispettivamente dal latino docere e monere e indicano in generale ciò che serve ad istruire, mostrare, provare e ciò che serve a ricordare (registrare) e informare. Possono essere utilizzati in diversi ambiti: non solo per i documenti, ma anche ‘reperti’ archeologici e artistici, per i fossili e strati geologici, per le fotografie e registrazioni e via dicendo. Il documento è oggetto di studio della Diplomatica, che si basa su un’analisi critica delle forme del documento, cercando di ricostruirne il processo di formazione, riconoscendone tempi e modi. La diplomatica individua tre persone che contribuiscono alla nascita del documento con i nomi di: autore, destinatario e scrittore. L’autore è colui che compie l’azione giuridica e che risulta essere anche autore del documento perché scritto da lui o per suo ordine o in suo nome. Colui che ordina o richiede la redazione del documento o colui al nome del quale il documento è intitolato, può anche essere una persona diversa dall’autore dell’azione giuridica. Il destinatario è la persona a cui è rivolta l’azione giuridica, il quale non è necessariamente colui a cui è indirizzato il documento, potendo quest’ultimo rivolgersi a persona diversa dal beneficiario. Lo scrittore è colui che provvede alla stesura del testo per libera professione o per pubblico ufficio su richiesta delle parti; questi nei documenti privati ha nomi diversi a seconda del tempo, del luogo e delle istituzioni vigenti. Di principale interesse per questa ricerca è la formazione del documento privato medievale che si differenzia a seconda del tempo, del luogo e degli istituti e consuetudini vigenti. Bisogna innanzitutto spiegare come si forma un documento: il processo formativo del documento, precisamente del documento privato, inizia con la rogatio; la domanda che viene rivolta allo scrittore di redigere il documento. Da questa fase lo scrittore prende nome di rogatario. Nel momento in cui si presentano dinanzi al rogatario le persone che richiedono la documentazione e la stesura dell’atto, il rogatario raccoglie i dati, stilando un primo abbozzo del documento chiamato minuta. Alla minuta segue la redactio in mundum, e precisamente la stesura definitiva del documento in cui agli appunti della minuta si aggiungono dei formulari che consistono in espressioni giuridiche e formule legali. La sottoscrizione rappresenta la quarta fase del processo formativo e comprende le sottoscrizioni delle parti, dei testimoni e del rogatario. Le sottoscrizioni, soprattutto dei testimoni, consistono nel caso di analfabeti in un signum, per la maggior parte di croce accanto alla quale viene indicato dallo scrittore il nome e la qualifica. In alcuni casi i signa manus non sono autografi ed esprimono solo l’approvazione del testimone che viene manifestata con l’apposizione della mano sulla carta. La funzione dei testimoni in principio era quella di attestare con la loro presenza la giuridicità dell’atto: questa era la situazione nel mondo romano in età tardo-imperiale e nei territori longobardi. Ma nel momento in cui il documento viene considerato una prova perché rogato da notai o tabellioni, la figura dei testimoni non è più necessaria. Nasce però un problema che riguarda l’intervento dei testimoni e più precisamente se questo avvenisse nel momento dell’azione o della documentazione. Il fatto che in molti documenti vi siano sottoscrizioni autografe dei testimoni farebbe pensare ad un loro intervento nel momento della documentazione, ma si deve considerare che spesso i loro nomi sono menzionati già nella minuta e inoltre per alcuni documenti dei quali ci sono pervenuti sia la minuta sia la redactio in mundum, si può notare che alcuni testimoni indicati nella prima non siano presenti nella seconda e/o viceversa; questo porterebbe a supporre una doppia testimonianza: una legata all’azione giuridica e l’altra alla documentazione . A cosa serve e perché si scrive un documento? Quali sono i fini della documentazione? Alessandro Pratesi ci dice che una delle difficoltà che si incontra nel ricostruire il processo di formazione del documento privato è riconoscerne il valore probante, valore che ci riporta quindi anche a quella che è diventata la nota definizione di documento di Cesare Paoli e di Alessandro Pratesi: “ Il documento è la testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, compilata, coll’osservanza di certe determinate forme, le quali sono destinate a procurarle fede e a darle forza di prova”; respingendo quelle che erano le teorie di Julius von Ficker e Heinrich Brunner, che approfondivano il problema della formazione del documento mettendo in rilievo la distinzione concettuale fra ‘azione giuridica’ e ‘documentazione’; e la funzione dispositiva del documento. Le origini del documento vanno ricercate già nell’antica Roma: qui i primi documenti sembrano essere stati i foedera o trattati internazionali, scritti su tavole di rame a memoria della parola data. Altro tipo di documentazione è costituita da quelle scritture che vengono redatte in forma di lista, elenco, ruolo o inventario; redatte per censire persone e/o beni ai fini dell’imposizione d’imposta e dell’arruolamento militare, o da quei ruoli militari e da quelle liste di magistrati che riproducono quadri della res publica, o da quegli elenchi del patrimonio pubblico immobiliare e mobiliare che servono per il bilancio: la funzione dei documenti di questo tipo molto probabilmente era quella di rilevare e rappresentare in ‘forme accertate’ e legali i dati che siano di riferimento e di base ad attività di vari e importanti settori dell’amministrazione pubblica. In ambito giurisdizionale, fra i secoli III a.C e III d.C, viene adottato e utilizzato dall’ordinamento giurisdizionale il processo formulare che consisteva nel dettare, da parte del magistrato, la formula cioè un documento complesso con il quale designava il giudice e gli indicava cosa doveva reputare vero o falso per poter sentenziare la condanna. A questi documenti si può attribuire sia una funzione dispositiva e cioè la manifestazione della volontà del magistrato, sia procedimentale cioè diretta a far partire e scandire i passaggi formali del procedimento. Per quanto riguarda l’ambito privatistico dei negozi giuridici, si fanno risalire al periodo preclassico due tipi di documenti: il testamento scritto su tavole cerate e il misterioso nomen transscripticium; “nel caso del testamento, al rito orale e simbolico dell’istituto del testamentum per aes et libram – e il simbolo sta appunto nei lingotti di bronzo e nella bilancia per pesarli – s’aggiunge l’uso, che diviene prassi, di redigere le disposizioni testamentarie su tavolette cerate, le quali vengono presentate chiuse al rito e ai testimoni, cosicché la scrittura viene a coincidere con la dichiarazione di volontà e il documento viene ad assumere funzione dispositiva, come peraltro esprime bene la nuncupatio o dichiarazione solenne del testatore con la formula haec ita, ut in his tabulis cerisque scripta sunt, ita do ita lego ita testor; nel secondo caso, la semplice e secca scritturazione a debito o a credito di una somma nel libro delle entrate e delle uscite o codex accepti et expensi, sembra aver avuto la funzione di formalizzare in astratto (e cioè a prescindere dalla causa negoziale) l’obbligazione di debito o credito.” Secondo Alessandro Pratesi il riconoscimento del valore probante del documento è una delle difficoltà che si incontra nella ricostruzione del processo di formazione del documento: è questo infatti un risultato che si è raggiunto col tempo. Tutti i popoli erano legati al fatto che le attestazioni scritte furono inizialmente e per lungo tempo destituite di ogni valore di prova. Quindi, l’atto scritto a Roma serviva solo per facilitare la prova e aiutare la memoria dei testimoni, sia che fosse redatto da scrivani al servizio di privati, cioè notarii, sia da scrittori di professione come stationarii o forenses e tabelliones; mentre nel mondo ellenistico era già frequente l’utilizzo di atti scritti ai quali si riconosceva piena efficacia oggettiva. Lo spostamento dell’impero a Costantinopoli fece sì che a imitazione dei Greci anche i Romani adottassero il documento autentico, l’autenticità del documento fu raggiunta attraverso il riconoscimento ad amministrazioni centrali, provinciali e municipali dello ius gestorum, ovvero della facoltà di accogliere nei propri registri i contratti dei privati e rilasciarne copie ufficiali. Questi documenti godevano di publica fides, come quelli giudiziari erano dei documenta publica che si distinguevano dai privata perché questi erano redatti da persone ai quali, pur essendo in grado di scrivere, non era riconosciuta questa attività. Quando la Penisola fu invasa dalle popolazioni barbariche queste trovarono le istituzioni romane ancora fiorenti e l’accolsero. Il conflitto che ne scaturì tra il diritto dei conquistatori e dei vinti, sfociò in un sistema nuovo, la cui evoluzione si ebbe con l’invasione longobarda. Questa infatti divise la Penisola in due: da una parte il Regno Italico governato dagli invasori e dall’altra regioni dominate o sotto influenza di Bisanzio. In queste regioni sopravvivono ancora i tabelliones mentre nei territori longobardi troviamo accanto a scrivani d’occasione, i professionisti che assumono il titolo di notarii. Ma tanto in zona longobarda quanto in zona bizantina l’importanza della scrittura è minima e riposa nelle sottoscrizioni dei testimoni. L’esigenza di conferire al documento un valore probatorio assoluto, porta nei territori romanici ad un graduale sviluppo del tabellionato. Nei territori longobardi invece vi era un solido ordinamento giudiziario con giudici indipendenti dai gastaldi e che agivano entro limiti territoriali precisi. Quando in Italia meridionale sopraggiungono i Normanni, le forme del documento in area a tradizione longobarda attraversano una fase di cambiamento. Infatti, mentre nei ducati costieri del basso Tirreno la carta curiale conserva ed accentua le forme tipiche di documentazione, nel resto del sud Italia sopravvivono la chartula e il memoratorium , le cui funzioni e caratteri diplomatistici sono diversi da quelli dei secoli precedenti. La struttura della chartula si compone di un protocollo, una narratio dichiarativa e una dispositio, dopo varie clausole tra cui la defensio, il testo si chiude con la rogatio. Mentre nel memoratorium dopo il protocollo, il testo inizia con una «memoratorium factum a me N.N de hoc quod», cui segue la narratio. Dopo la dispositio il testo non si chiude con la formula della rogatio ma bensì con la dichiarazione del notaio di aver scritto il documento “eo quod interfui”. Fino all’XI secolo il rapporto che si riscontra tra queste due strutture in Italia meridionale pone la chartula come un’azione giuridica, il memoratorium come un documento accessorio che viene rogato dallo stesso notaio e alla stessa data, con il quale il destinatario di un contratto di alienazione richiede e ottiene dai congiunti dell’alienante garanzie per il pacifico possesso del bene acquisito. Questi tipi di memoratoria sono riflesso di un’incertezza del diritto, riscontrabile in modo più particolare in periferia, e non nei centri della Longobardia minore come Benevento, Capua e Salerno. Inoltre questi memoratoria sono scritti a nome di persone che spesso appartengono a classi subalterne. Questo quadro documentale è in crisi già da mezzo secolo, quando si afferma il dominio normanno con conseguente nuova realtà costituzionale del Regnum in Italia meridionale. Si incontrano e diventano sempre più numerosi i memoratoria che attraverso il negozio della convenientia, documentano sostanzialmente gli stessi negozi attestati dalla chartula, indebolendosi in questo modo lo scopo a cui erano destinati le due tipologie di documento. Un indizio di questa crisi è il prevalere nel linguaggio dei notai, del termine scriptum sulle voci chartula, memoratorium e breve: un termine antico di due secoli ma che acquistava ora un senso nuovo. Un nuovo problema si pone quindi per la figura del notaio, che nella Longobardia minore si presenta a partire dalla fine del secolo IX, come unico depositario della facoltà di rogare documenti. La confusione tra le due strutture documentali della chartula e del memoratorium fa si che anche nella prima, il notaio tende a far risaltare la funzione del proprio intervento dichiarando di aver proceduto alla redazione poiché presente alla stipula del contratto. In questo modo esso si presenta non più come un semplice amanuense che verbalizzi un qualsiasi evento, ma come garante della corrispondenza tra volontà delle parti e attestazione scritta, perché testimone e interprete dell’azione giuridica. Cominciano ad apparire anche se in modo saltuario figure che ricoprono contemporaneamente la l’ufficio di giudice e quello di notaio. Fenomeno particolarmente importante perché volendo legare la fides del documento a chi era investito anche di una funzione giudiziaria, denunciava il disagio di dover riconoscere capacitò certificante a chi non aveva per il proprio ufficio altra base che le consuetudini locali e inoltre si assisteva a una cura maggiore sia per le forme grafiche sia per il dettato dei documenti e il fenomeno coincideva con la diminuzione dei rogatari ecclesiastici anche in località nelle quali le leve del notariato provenivano esclusivamente o quasi da questa categoria. Con il dominio dei Carolingi, lo svilupparsi di questo ordinamento e l’articolarsi dei notai in varie categorie aprirono la strada al riconoscimento dell’autenticità attraverso il ricorso al tribunale. Col passare del tempo il documento si libera di questa procedura, arrivando alla semplice sottoscrizione del giudice come garanzia dei rapporti del diritto non contestato e nei territori a regime notarile le funzioni di giudice e notaio sono svolte dalla stessa persona. Il notarius in Italia meridionale indica il rogatario che non sottoscrive il documento ma dichiara di averlo redatto e quindi la credibilità dello scritto è affidata alla sottoscrizione dei testimoni. Il documento privato raggiunge la piena credibilità in modo lento e questa scaturisce dall’acquisizione del prestigio del rogatario che si basa sulla fiducia che hanno le parti di trovare in lui sia il perfetto redattore della loro volontà sia il sicuro custode dei contratti stipulati dalla sua clientela nel corso degli anni. Questo rapporto di fiducia non significa automaticamente la piena credibilità del documento che viene stabilita necessariamente da una sanzione legislativa, ma la fiducia verso la figura del rogatario è alla base del valore probatorio del prodotto notarile. Diventa quindi molto importante la conservazione delle minute presso i rogatari che le trasmettono ai loro successori consentendo in questo modo di poter sempre ricavare il documento. Tra il XII e XIII secolo, in gran parte del territorio italiano e altrove si assiste al trionfo dell’istituto notarile, il documento ha valore probante per il solo fatto di essere stato rogato dal notaio. L’autenticazione del documento avveniva attraverso l’apposizione del signum tabellionatus e la sottoscrizione del notarius. L’Italia è stato il primo paese nel quale il notaio ottenne il riconoscimento della publica fides e quindi il primo in cui il signum tabellionatus si affermò come mezzo di autenticazione. Il signum tabellionatus ha origini antiche, veniva tracciato o disegnato a mano in ogni documento rogato e riproduceva il monogramma del notaio. Sebbene attestato già in epoca altomedievale, i signa tabellionatus acquistano le loro caratteristiche di autenticità, solo nell’XI secolo, o più prescisamente quando al documento viene riconosciuta publica fides. A causa dell’alfabetismo che predominava nel Medioevo, al termine dello scritto compariva una croce, con quattro punti nei quattro quadranti seguita dal nome di ciascuna persona: in ultimo la firma, la croce o il segno, o due o tutti e tre i simboli dello scriba, predecessore del notaio. Si trattava del signum manus, considerato dal Guige come antenato del contrassegno notarile. Sulle origini del signum un’antica leggenda catalana narrava che un signore moribondo voleva fare testamento ma non sapendo o riuscendo a scrivere , il notaio segnò alla fine dell’atto una croce e tre quadranti apponendo tre punti, invitando poi l’uomo ad aggiungere l’altro punto nel quarto quadrante. Questa leggenda fa capire che la croce puntata era una delle forme originali del signum e che il quarto punto stava ad indicare una persona analfabeta. Altra possibile origine del signum notarile si individuò nel Chrismon utilizzato già da Carlo Magno, insegna cristiana che ricordava i simboli scolpiti nelle sepolture cristiane dei primi secoli, cioè le lettere greche delle iniziali del Cristo, X e P. Dal segno della croce , dal XI sec., il signum si evolve fino ad avere nel XIII secolo un carattere ornamentale, con fregi decorativi diventando contrassegno personale che permetteva di distinguere il singolo notaio. Questo poteva essere modificato solo con concessione sovrana, e si poteva tramandare in caso di sostituzione o eredità. Nel primo caso il nuovo notaio adottava il segno tabellionare del primo apportando qualche modifica, mentre nel secondo il figlio ereditava il signum dal padre, anche questo poteva apportare parziali modifiche. Questi cambiamenti erano necessari per la personalizzazione dei signa. Nei signa medievali si trovano quasi sempre tre elementi costanti: la croce , nella forma latina o greca o di Sant’Andrea , simbolo che molto probabilmente rappresentava l’invocazione della divina protezione dei notai roganti ma anche delle parti costituite negli atti notarili. Il nodo o pergamena intrecciata a nodo simbolo dell’ Ars notaria che si rinviene in forma stilizzata. Infine, il monogramma che costituiva generalmente la lettera iniziale del nome del notaio. Dal XII secolo alla figura del signum crucis si affiancano altre tipologie di signa: diventano infatti frequenti l’uso di immagini che riproducono forme geometriche, floreali, antropomorfe e di animali . Ci sono poi signa che vengono definiti parlanti, che sono costituiti da lettere, giochi di parole o figure e che facevano riferimento al nome proprio del rogatario e di cui si porta come esempio in Ego notarius, quello del notaio romano Fortebraccio, rappresentato da un braccio piegato . Essendo il signum contrassegno personale del notaio che quindi ne permetteva inconfondibile individuazione, per evitare contraffazioni o per individuare contrassegni di notai omonimi, lo studio di Leone circoscritto ai documenti salernitani dell’archivio della Badia di Cava, rilevava come dalla fine del sec.VIII era diventata consuetudine dei notai riempire lo spazio vuoto della parte finale degli atti con ghirigori che si originavano dal prolungamento del segno manuale.
I termini documento e monumento derivano rispettivamente dal latino docere e monere e indicano in generale ciò che serve ad istruire, mostrare, provare e ciò che serve a ricordare (registrare) e informare. Possono essere utilizzati in diversi ambiti: non solo per i documenti, ma anche ‘reperti’ archeologici e artistici, per i fossili e strati geologici, per le fotografie e registrazioni e via dicendo. Il documento è oggetto di studio della Diplomatica, che si basa su un’analisi critica delle forme del documento, cercando di ricostruirne il processo di formazione, riconoscendone tempi e modi. La diplomatica individua tre persone che contribuiscono alla nascita del documento con i nomi di: autore, destinatario e scrittore. L’autore è colui che compie l’azione giuridica e che risulta essere anche autore del documento perché scritto da lui o per suo ordine o in suo nome. Colui che ordina o richiede la redazione del documento o colui al nome del quale il documento è intitolato, può anche essere una persona diversa dall’autore dell’azione giuridica. Il destinatario è la persona a cui è rivolta l’azione giuridica, il quale non è necessariamente colui a cui è indirizzato il documento, potendo quest’ultimo rivolgersi a persona diversa dal beneficiario. Lo scrittore è colui che provvede alla stesura del testo per libera professione o per pubblico ufficio su richiesta delle parti; questi nei documenti privati ha nomi diversi a seconda del tempo, del luogo e delle istituzioni vigenti. Di principale interesse per questa ricerca è la formazione del documento privato medievale che si differenzia a seconda del tempo, del luogo e degli istituti e consuetudini vigenti. Bisogna innanzitutto spiegare come si forma un documento: il processo formativo del documento, precisamente del documento privato, inizia con la rogatio; la domanda che viene rivolta allo scrittore di redigere il documento. Da questa fase lo scrittore prende nome di rogatario. Nel momento in cui si presentano dinanzi al rogatario le persone che richiedono la documentazione e la stesura dell’atto, il rogatario raccoglie i dati, stilando un primo abbozzo del documento chiamato minuta. Alla minuta segue la redactio in mundum, e precisamente la stesura definitiva del documento in cui agli appunti della minuta si aggiungono dei formulari che consistono in espressioni giuridiche e formule legali. La sottoscrizione rappresenta la quarta fase del processo formativo e comprende le sottoscrizioni delle parti, dei testimoni e del rogatario. Le sottoscrizioni, soprattutto dei testimoni, consistono nel caso di analfabeti in un signum, per la maggior parte di croce accanto alla quale viene indicato dallo scrittore il nome e la qualifica. In alcuni casi i signa manus non sono autografi ed esprimono solo l’approvazione del testimone che viene manifestata con l’apposizione della mano sulla carta. La funzione dei testimoni in principio era quella di attestare con la loro presenza la giuridicità dell’atto: questa era la situazione nel mondo romano in età tardo-imperiale e nei territori longobardi. Ma nel momento in cui il documento viene considerato una prova perché rogato da notai o tabellioni, la figura dei testimoni non è più necessaria. Nasce però un problema che riguarda l’intervento dei testimoni e più precisamente se questo avvenisse nel momento dell’azione o della documentazione. Il fatto che in molti documenti vi siano sottoscrizioni autografe dei testimoni farebbe pensare ad un loro intervento nel momento della documentazione, ma si deve considerare che spesso i loro nomi sono menzionati già nella minuta e inoltre per alcuni documenti dei quali ci sono pervenuti sia la minuta sia la redactio in mundum, si può notare che alcuni testimoni indicati nella prima non siano presenti nella seconda e/o viceversa; questo porterebbe a supporre una doppia testimonianza: una legata all’azione giuridica e l’altra alla documentazione . A cosa serve e perché si scrive un documento? Quali sono i fini della documentazione? Alessandro Pratesi ci dice che una delle difficoltà che si incontra nel ricostruire il processo di formazione del documento privato è riconoscerne il valore probante, valore che ci riporta quindi anche a quella che è diventata la nota definizione di documento di Cesare Paoli e di Alessandro Pratesi: “ Il documento è la testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, compilata, coll’osservanza di certe determinate forme, le quali sono destinate a procurarle fede e a darle forza di prova”; respingendo quelle che erano le teorie di Julius von Ficker e Heinrich Brunner, che approfondivano il problema della formazione del documento mettendo in rilievo la distinzione concettuale fra ‘azione giuridica’ e ‘documentazione’; e la funzione dispositiva del documento. Le origini del documento vanno ricercate già nell’antica Roma: qui i primi documenti sembrano essere stati i foedera o trattati internazionali, scritti su tavole di rame a memoria della parola data. Altro tipo di documentazione è costituita da quelle scritture che vengono redatte in forma di lista, elenco, ruolo o inventario; redatte per censire persone e/o beni ai fini dell’imposizione d’imposta e dell’arruolamento militare, o da quei ruoli militari e da quelle liste di magistrati che riproducono quadri della res publica, o da quegli elenchi del patrimonio pubblico immobiliare e mobiliare che servono per il bilancio: la funzione dei documenti di questo tipo molto probabilmente era quella di rilevare e rappresentare in ‘forme accertate’ e legali i dati che siano di riferimento e di base ad attività di vari e importanti settori dell’amministrazione pubblica. In ambito giurisdizionale, fra i secoli III a.C e III d.C, viene adottato e utilizzato dall’ordinamento giurisdizionale il processo formulare che consisteva nel dettare, da parte del magistrato, la formula cioè un documento complesso con il quale designava il giudice e gli indicava cosa doveva reputare vero o falso per poter sentenziare la condanna. A questi documenti si può attribuire sia una funzione dispositiva e cioè la manifestazione della volontà del magistrato, sia procedimentale cioè diretta a far partire e scandire i passaggi formali del procedimento. Per quanto riguarda l’ambito privatistico dei negozi giuridici, si fanno risalire al periodo preclassico due tipi di documenti: il testamento scritto su tavole cerate e il misterioso nomen transscripticium; “nel caso del testamento, al rito orale e simbolico dell’istituto del testamentum per aes et libram – e il simbolo sta appunto nei lingotti di bronzo e nella bilancia per pesarli – s’aggiunge l’uso, che diviene prassi, di redigere le disposizioni testamentarie su tavolette cerate, le quali vengono presentate chiuse al rito e ai testimoni, cosicché la scrittura viene a coincidere con la dichiarazione di volontà e il documento viene ad assumere funzione dispositiva, come peraltro esprime bene la nuncupatio o dichiarazione solenne del testatore con la formula haec ita, ut in his tabulis cerisque scripta sunt, ita do ita lego ita testor; nel secondo caso, la semplice e secca scritturazione a debito o a credito di una somma nel libro delle entrate e delle uscite o codex accepti et expensi, sembra aver avuto la funzione di formalizzare in astratto (e cioè a prescindere dalla causa negoziale) l’obbligazione di debito o credito.” Secondo Alessandro Pratesi il riconoscimento del valore probante del documento è una delle difficoltà che si incontra nella ricostruzione del processo di formazione del documento: è questo infatti un risultato che si è raggiunto col tempo. Tutti i popoli erano legati al fatto che le attestazioni scritte furono inizialmente e per lungo tempo destituite di ogni valore di prova. Quindi, l’atto scritto a Roma serviva solo per facilitare la prova e aiutare la memoria dei testimoni, sia che fosse redatto da scrivani al servizio di privati, cioè notarii, sia da scrittori di professione come stationarii o forenses e tabelliones; mentre nel mondo ellenistico era già frequente l’utilizzo di atti scritti ai quali si riconosceva piena efficacia oggettiva. Lo spostamento dell’impero a Costantinopoli fece sì che a imitazione dei Greci anche i Romani adottassero il documento autentico, l’autenticità del documento fu raggiunta attraverso il riconoscimento ad amministrazioni centrali, provinciali e municipali dello ius gestorum, ovvero della facoltà di accogliere nei propri registri i contratti dei privati e rilasciarne copie ufficiali. Questi documenti godevano di publica fides, come quelli giudiziari erano dei documenta publica che si distinguevano dai privata perché questi erano redatti da persone ai quali, pur essendo in grado di scrivere, non era riconosciuta questa attività. Quando la Penisola fu invasa dalle popolazioni barbariche queste trovarono le istituzioni romane ancora fiorenti e l’accolsero. Il conflitto che ne scaturì tra il diritto dei conquistatori e dei vinti, sfociò in un sistema nuovo, la cui evoluzione si ebbe con l’invasione longobarda. Questa infatti divise la Penisola in due: da una parte il Regno Italico governato dagli invasori e dall’altra regioni dominate o sotto influenza di Bisanzio. In queste regioni sopravvivono ancora i tabelliones mentre nei territori longobardi troviamo accanto a scrivani d’occasione, i professionisti che assumono il titolo di notarii. Ma tanto in zona longobarda quanto in zona bizantina l’importanza della scrittura è minima e riposa nelle sottoscrizioni dei testimoni. L’esigenza di conferire al documento un valore probatorio assoluto, porta nei territori romanici ad un graduale sviluppo del tabellionato. Nei territori longobardi invece vi era un solido ordinamento giudiziario con giudici indipendenti dai gastaldi e che agivano entro limiti territoriali precisi. Quando in Italia meridionale sopraggiungono i Normanni, le forme del documento in area a tradizione longobarda attraversano una fase di cambiamento. Infatti, mentre nei ducati costieri del basso Tirreno la carta curiale conserva ed accentua le forme tipiche di documentazione, nel resto del sud Italia sopravvivono la chartula e il memoratorium , le cui funzioni e caratteri diplomatistici sono diversi da quelli dei secoli precedenti. La struttura della chartula si compone di un protocollo, una narratio dichiarativa e una dispositio, dopo varie clausole tra cui la defensio, il testo si chiude con la rogatio. Mentre nel memoratorium dopo il protocollo, il testo inizia con una «memoratorium factum a me N.N de hoc quod», cui segue la narratio. Dopo la dispositio il testo non si chiude con la formula della rogatio ma bensì con la dichiarazione del notaio di aver scritto il documento “eo quod interfui”. Fino all’XI secolo il rapporto che si riscontra tra queste due strutture in Italia meridionale pone la chartula come un’azione giuridica, il memoratorium come un documento accessorio che viene rogato dallo stesso notaio e alla stessa data, con il quale il destinatario di un contratto di alienazione richiede e ottiene dai congiunti dell’alienante garanzie per il pacifico possesso del bene acquisito. Questi tipi di memoratoria sono riflesso di un’incertezza del diritto, riscontrabile in modo più particolare in periferia, e non nei centri della Longobardia minore come Benevento, Capua e Salerno. Inoltre questi memoratoria sono scritti a nome di persone che spesso appartengono a classi subalterne. Questo quadro documentale è in crisi già da mezzo secolo, quando si afferma il dominio normanno con conseguente nuova realtà costituzionale del Regnum in Italia meridionale. Si incontrano e diventano sempre più numerosi i memoratoria che attraverso il negozio della convenientia, documentano sostanzialmente gli stessi negozi attestati dalla chartula, indebolendosi in questo modo lo scopo a cui erano destinati le due tipologie di documento. Un indizio di questa crisi è il prevalere nel linguaggio dei notai, del termine scriptum sulle voci chartula, memoratorium e breve: un termine antico di due secoli ma che acquistava ora un senso nuovo. Un nuovo problema si pone quindi per la figura del notaio, che nella Longobardia minore si presenta a partire dalla fine del secolo IX, come unico depositario della facoltà di rogare documenti. La confusione tra le due strutture documentali della chartula e del memoratorium fa si che anche nella prima, il notaio tende a far risaltare la funzione del proprio intervento dichiarando di aver proceduto alla redazione poiché presente alla stipula del contratto. In questo modo esso si presenta non più come un semplice amanuense che verbalizzi un qualsiasi evento, ma come garante della corrispondenza tra volontà delle parti e attestazione scritta, perché testimone e interprete dell’azione giuridica. Cominciano ad apparire anche se in modo saltuario figure che ricoprono contemporaneamente la l’ufficio di giudice e quello di notaio. Fenomeno particolarmente importante perché volendo legare la fides del documento a chi era investito anche di una funzione giudiziaria, denunciava il disagio di dover riconoscere capacitò certificante a chi non aveva per il proprio ufficio altra base che le consuetudini locali e inoltre si assisteva a una cura maggiore sia per le forme grafiche sia per il dettato dei documenti e il fenomeno coincideva con la diminuzione dei rogatari ecclesiastici anche in località nelle quali le leve del notariato provenivano esclusivamente o quasi da questa categoria. Con il dominio dei Carolingi, lo svilupparsi di questo ordinamento e l’articolarsi dei notai in varie categorie aprirono la strada al riconoscimento dell’autenticità attraverso il ricorso al tribunale. Col passare del tempo il documento si libera di questa procedura, arrivando alla semplice sottoscrizione del giudice come garanzia dei rapporti del diritto non contestato e nei territori a regime notarile le funzioni di giudice e notaio sono svolte dalla stessa persona. Il notarius in Italia meridionale indica il rogatario che non sottoscrive il documento ma dichiara di averlo redatto e quindi la credibilità dello scritto è affidata alla sottoscrizione dei testimoni. Il documento privato raggiunge la piena credibilità in modo lento e questa scaturisce dall’acquisizione del prestigio del rogatario che si basa sulla fiducia che hanno le parti di trovare in lui sia il perfetto redattore della loro volontà sia il sicuro custode dei contratti stipulati dalla sua clientela nel corso degli anni. Questo rapporto di fiducia non significa automaticamente la piena credibilità del documento che viene stabilita necessariamente da una sanzione legislativa, ma la fiducia verso la figura del rogatario è alla base del valore probatorio del prodotto notarile. Diventa quindi molto importante la conservazione delle minute presso i rogatari che le trasmettono ai loro successori consentendo in questo modo di poter sempre ricavare il documento. Tra il XII e XIII secolo, in gran parte del territorio italiano e altrove si assiste al trionfo dell’istituto notarile, il documento ha valore probante per il solo fatto di essere stato rogato dal notaio. L’autenticazione del documento avveniva attraverso l’apposizione del signum tabellionatus e la sottoscrizione del notarius. L’Italia è stato il primo paese nel quale il notaio ottenne il riconoscimento della publica fides e quindi il primo in cui il signum tabellionatus si affermò come mezzo di autenticazione. Il signum tabellionatus ha origini antiche, veniva tracciato o disegnato a mano in ogni documento rogato e riproduceva il monogramma del notaio. Sebbene attestato già in epoca altomedievale, i signa tabellionatus acquistano le loro caratteristiche di autenticità, solo nell’XI secolo, o più prescisamente quando al documento viene riconosciuta publica fides. A causa dell’alfabetismo che predominava nel Medioevo, al termine dello scritto compariva una croce, con quattro punti nei quattro quadranti seguita dal nome di ciascuna persona: in ultimo la firma, la croce o il segno, o due o tutti e tre i simboli dello scriba, predecessore del notaio. Si trattava del signum manus, considerato dal Guige come antenato del contrassegno notarile. Sulle origini del signum un’antica leggenda catalana narrava che un signore moribondo voleva fare testamento ma non sapendo o riuscendo a scrivere , il notaio segnò alla fine dell’atto una croce e tre quadranti apponendo tre punti, invitando poi l’uomo ad aggiungere l’altro punto nel quarto quadrante. Questa leggenda fa capire che la croce puntata era una delle forme originali del signum e che il quarto punto stava ad indicare una persona analfabeta. Altra possibile origine del signum notarile si individuò nel Chrismon utilizzato già da Carlo Magno, insegna cristiana che ricordava i simboli scolpiti nelle sepolture cristiane dei primi secoli, cioè le lettere greche delle iniziali del Cristo, X e P. Dal segno della croce , dal XI sec., il signum si evolve fino ad avere nel XIII secolo un carattere ornamentale, con fregi decorativi diventando contrassegno personale che permetteva di distinguere il singolo notaio. Questo poteva essere modificato solo con concessione sovrana, e si poteva tramandare in caso di sostituzione o eredità. Nel primo caso il nuovo notaio adottava il segno tabellionare del primo apportando qualche modifica, mentre nel secondo il figlio ereditava il signum dal padre, anche questo poteva apportare parziali modifiche. Questi cambiamenti erano necessari per la personalizzazione dei signa. Nei signa medievali si trovano quasi sempre tre elementi costanti: la croce , nella forma latina o greca o di Sant’Andrea , simbolo che molto probabilmente rappresentava l’invocazione della divina protezione dei notai roganti ma anche delle parti costituite negli atti notarili. Il nodo o pergamena intrecciata a nodo simbolo dell’ Ars notaria che si rinviene in forma stilizzata. Infine, il monogramma che costituiva generalmente la lettera iniziale del nome del notaio. Dal XII secolo alla figura del signum crucis si affiancano altre tipologie di signa: diventano infatti frequenti l’uso di immagini che riproducono forme geometriche, floreali, antropomorfe e di animali . Ci sono poi signa che vengono definiti parlanti, che sono costituiti da lettere, giochi di parole o figure e che facevano riferimento al nome proprio del rogatario e di cui si porta come esempio in Ego notarius, quello del notaio romano Fortebraccio, rappresentato da un braccio piegato . Essendo il signum contrassegno personale del notaio che quindi ne permetteva inconfondibile individuazione, per evitare contraffazioni o per individuare contrassegni di notai omonimi, lo studio di Leone circoscritto ai documenti salernitani dell’archivio della Badia di Cava, rilevava come dalla fine del sec.VIII era diventata consuetudine dei notai riempire lo spazio vuoto della parte finale degli atti con ghirigori che si originavano dal prolungamento del segno manuale.
La scrittura dei documenti notarili
In Italia dai secoli VII e VIII fino al XII e XIII, la scrittura che viene regolarmente utilizzata è la minuscola corsiva. Questa viene utilizzata sia durante il regno ostrogoto, che si può definire culturalmente ancora latino, sia quando con la conquista longobarda l’Italia resta divisa in due territori distinti: quello longobardo che comprendeva l’Italia settentrionale, la Tuscia, i ducati di Spoleto e di Benevento e quello romanico che oltre l’Esarcato di Ravenna e la Pentapoli, anche il ducato romano, il ducato napoletano, le Puglie, la Calabria e le isole. L’evoluzione della scrittura che muove dalla minuscola corsiva è conseguenza della perdita del senso di una fonte comune del sistema grafico corsivo-librario. Divengono sempre più numerosi processi locali che portano a una diversificazione geografica della scrittura che permettono una facile e sicura localizzazione di carte non datate. A partire dalla metà del IX secolo quando negli scrittori italiani di area settentrionale e centrale si adotta la minuscola rotonda o carolina per i libri, nelle scuole letterarie si insegnerà esclusivamente la scrittura dei libri che si trasformerà ben presto in usuale. Questa sostituirà la corsiva in tutti gli usi, ma tale sostituzione non sarà uguale in tutte le zone d’Italia. Nei luoghi che non avevano subito l’invasione longobarda o nei quali era stata predominante la dominazione bizantina, si erano conservate le curie cittadine, gli scribi dei documenti continuano ad utilizzare la “ vecchia corsiva nuova”, che da quel momento diventerà esclusivamente scrittura documentaria. Volendo intendere con il termine documentaria, la documentazione di atti giuridici, e quindi diviene scrittura notarile. Più articolato invece è l’evoluzione della corsiva nuova nel Mezzogiorno d’Italia, dove nei secoli dal VII al XII le città più importanti avevano ciascuna la propria curia notarile che elaborava la scrittura dei documenti in forme cancelleresche. Verso la fine dell’VIII secolo, nel Principato di Benevento si diffonde una scrittura, la beneventana. Questa nasce come scrittura libraria, e ha origine nello scriptorium monastico di Montecassino, ma troverà applicazione anche nell’uso comune, come è dimostrato da numerose sottoscrizioni di carte di privati. Infatti, fra il IX e il X secolo, la corsiva nuova dei rogatari assume forme e aspetti della beneventana di ambito documentario. Con l’invasione dei Normanni, in campo documentario alla corsiva o alle cancelleresche di tipo beneventano si sostituì la minuscola diplomatica carolina, scrittura utilizzata sia nelle cancellerie dei signori minori, sia dai singoli notai per la redazione degli atti privati . Nel XII secolo, momento di notevole incremento della produzione documentaria con conseguente affermazione del ruolo del notaio, quest’ultimo tende a differenziare le scritture che produce secondo le necessità e le richieste di coloro che ricorrono a lui; grazie anche all’utilizzo della carta per gli atti preparatori del documento. Aspetto importante perché proprio nelle differenti redazioni del documento si può notare anche una differenziazione grafica. Un’evoluzione grafica interno al sistema della carolina e che tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo porta alla creazione di una nuova scrittura: la littera minuta corsiva o cancelleresca.
Per la mostra, che inauguriamo in occasione del primo corso di Calligrafia dell’Associazione, presentiamo i seguenti documenti conservati in Archivio. Una Bolla del primo Canonicato del reverendo Antonino designato dal reverendo Don Carlo Cuto canonico dell’Insigne Real Collegio di Gesualdo a suo nipote Lorenzo Cuto nell’anno 1723 e una Bolla del fu Don Alessio Primicerio Catone anno 1781, documenti in pergamena. Conserviamo due pagine di incunabolo del Serta Etas Mundi, CLXXII. Cronaca di Norimberga, 1493. Due pagine con miniature della Linea dei Papi- Bonifacio, Stefano, Romani e Teodoro- e la Linea degli Imperatori – Carlo II, Carlo III . Dall’Archivio privato della Famiglia Amato- Iorio, dei documenti privati , lettere e conti di bilancio. Lettera del Sindaco di Potenza Santangelo al Signor Cassiere Comunale del 5 luglio 1813. Resoconto del Bilancio di Introito ed Esito, reso dal Sindaco di Potenza Signor Giacinto Amato per l’esercizio del 1811, redatto da Nicola Santangelo Uditore al Consiglio di Stato ed Intendente di Basilicata in data 27 novembre 1812. Lettera di risposta a Giacinto Amato alla sua richiesta di messa in regola di un affare di Don Matteo e alla richiesta di notamento, del settembre 1816. Conto tra Amati e Iorio dal 1 Gennaio 1811 a tutto il di 12 Agosto come Sindaco e Cassiere , del 12 settembre 1811. Lettera a Don Pasqualino Amato da parte di Don Pietro Barbariello del 30 dicembre 1863 nella quale lamenta che non sia ancora iniziato il processo penale contro la fabbrica dopo la convalida del sequestro.
Si conservano inoltre nello stesso archivio anche delle schede di esercizi di calligrafia del Corsivo inglese, piccolo e mezzano.
Dall’archivio del Fondo Fusco due documenti sia della sfera pubblica che privata. Lezioni di Leggi Civili. 1852. “ Dei differenti modi di acquistare i diritti reali e personali”. Quaderno di appunti ad uso personale di Francesco Paolo Borag[hi]. 32 parti relative alle molteplici modalità di acquisizione dei diritti reali quali eredità, titolo e simili. Stato Pontificio-Delegazione di Benevento. Preventivo parziale dei lavori Comunali di Primo grado di urgenza a garanzia del Ponte detto Valentino per l’esercizio del 1830.
- Associazione Amici degli Archivi Onlus
Pergamena – Bolla del primo Canonicato del reverendo Antonino designato dal reverendo Don Carlo Cuto canonico dell’Insigne Real Collegio di Gesualdo a suo nipote Lorenzo Cuto nell’anno 1723
- Associazione Amici degli Archivi Onlus
Pergamena – Bolla del fu Don Alessio Primicerio Catone anno 1781
- Associazione Amici degli Archivi Onlus
Serta Etas Mundi, CLXXII. Cronaca di Norimberga, 1493. Due pagine con miniature della Linea dei Papi- Bonifacio, Stefano, Romani e Teodoro- e la Linea degli Imperatori – Carlo II, Carlo III –
- Associazione Amici degli Archivi Onlus – Famiglia Amato-Iorio
Lettera del Sindaco di Potenza Santangelo al Signor Cassiere Comunale del 5 luglio 1813
- Associazione Amici degli Archivi Onlus – Famiglia Amato-Iorio
Resoconto del Bilancio di Introito ed Esito, reso dal Sindaco di Potenza Signor Giacinto Amato per l’esercizio del 1811, redatto da Nicola Santangelo Uditore al Consiglio di Stato ed Intendente di Basilicata in data 27 novembre 1812
- Associazione Amici degli Archivi Onlus – Famiglia Amato-Iorio
Lettera di risposta a Giacinto Amato alla sua richiesta di messa in regola di un affare di Don Matteo e alla richiesta di notamento, del settembre 1816
- Associazione Amici degli Archivi Onlus– Famiglia Amato-Iorio
Conto tra Amati e Iorio dal 1 Gennaio 1811 a tutto il di 12 Agosto come Sindaco e Cassiere , del 12 settembre 1811
- Associazione Amici degli Archivi Onlus – Famiglia Amato-Iorio
Lettera a Don Pasqualino Amato da parte di Don Pietro Barbariello del 30 dicembre 1863 nella quale lamenta che non sia ancora iniziato il processo penale contro la fabbrica dopo la convalida del sequestro.
- Associazione Amici degli Archivi Onlus – Famiglia Amato-Iorio
Tre schede di esercizi di calligrafia di corsivo Inglese, piccolo e mezzano.
- Associazione Amici degli Archivi Onlus- Fondo Fusco
Lezioni di Leggi Civili. 1852. “ Dei differenti modi di acquistare i diritti reali e personali”. Quaderno di appunti ad uso personale di Francesco Paolo Borag[hi]. 32 parti relative alle molteplici modalità di acquisizione dei diritti reali quali eredità, titolo e simili.
- Associazione Amici degli Archivi Onlus- Fondo Fusco
Stato Pontificio-Delegazione di Benevento. Preventivo parziale dei lavori Comunali di Primo grado di urgenza a garanzia del Ponte detto Valentino per l’esercizio del 1830.